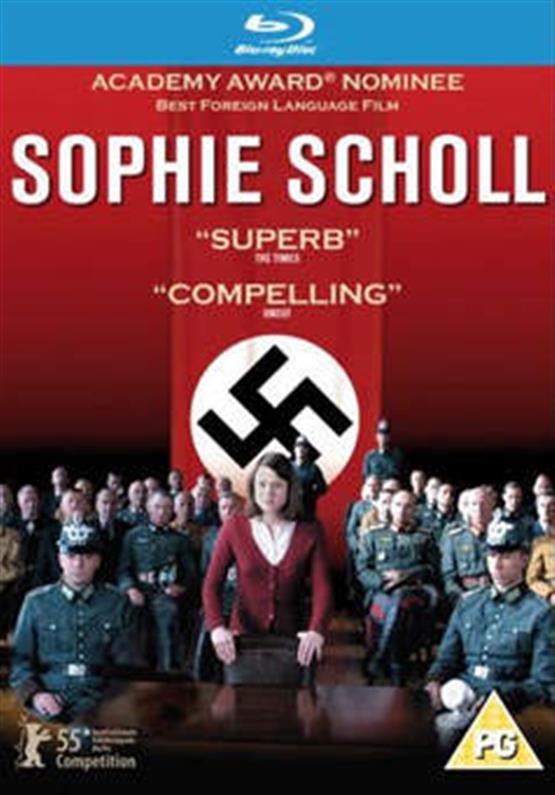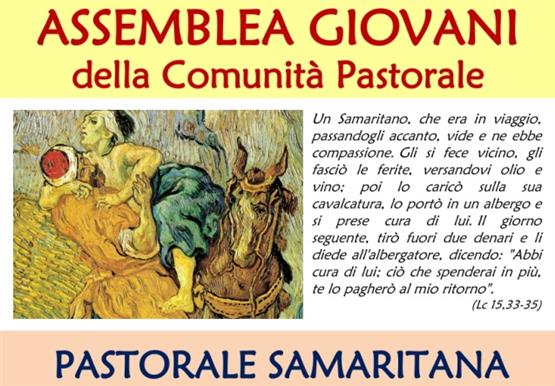Il bestiario di san Sigismondo a Rivolta d’Adda. Curiosando sulle tracce della bellezza sono molte le scoperte sorprendenti della nostra Martesana.
Ero già stato a Rivolta d’Adda con i nipotini a vedere il
divertente Parco della Preistoria abitato da enormi dinosauri realistici nelle
forme e fantastici nei colori. Ci torno in una giornata di sole per visitare la
chiesa romanica di Santa Maria Assunta e San Sigismondo, chiusa in una piazza
che nell’impianto ricorda i borghi medievali. Fu consacrata probabilmente tra
il 1095 e il 1096 da papa Urbano II nel suo viaggio in Lombardia e in Francia;
costruita e progettata dopo la conquista milanese di Rivolta presenta evidenti
analogie con la basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Tra il 1902 e il 1907
l’architetto Nava procedette ad un radicale e (per gli odierni criteri)
discutibile restauro per eseguire il quale venne venduta la “Pace di Rivolta
d’Adda”, tabernacolo del Quattrocento ora al Museo Poldi Pezzoli di Milano.
Infatti il nartece addossato alla facciata fu totalmente ricostruito partendo
dalle tracce degli archi ivi esistenti. Molto bella è la parte absidale esterna
che ricorda San Michele a Pavia; particolare è in questa chiesa la mancanza di
tiburio mentre l’interno ricorda Sant’Ambrogio, ma senza i matronei e con tre
tipi diversi di coperture della volta. Gli interessanti affreschi che compaiono nell’abside centrale
rappresentano l’Ultima cena. I capitelli di San Sigismondo costituiscono uno
dei repertori più belli di tutta la scultura romanica lombarda, pur nella
consapevolezza che il restauro novecentesco ha fatto avanzare forti dubbi
sull’autenticità di parte di essi (è emerso un preventivo dove figuravano ben 36
mezzi capitelli da rifare!). A questo punto ho cominciato a curiosare tra i
capitelli scolpiti scoprendo un altro bestiario nascosto, parallelo a quello
del vicino Parco. Ecco che appaiono due animali simili a lupi che si
fronteggiano, simbolo di cattivi maestri e di falsi profeti, nell’apologetica
cristiana persino di carnefici dei martiri. Fortunatamente abbiamo fatto pace
con queste bestie. In facciata un grifone alato piomba sopra un inerme coniglio
che fugge terrorizzato mentre all’interno un leone assale un cervo ormai arreso.
L’agnello sovrastato da un’enorme croce
astile è il richiamo più evidente al sacrificio di Cristo. Ma che dire delle
sirene, qui presenti in due versioni: nel primo caso una sirena con due code
completamente vestita e con due serpenti che le mordicchiano le folte chiome;
nel secondo sotto la sirena, che stringe le code tra le mani, i serpenti si
fronteggiano. La sirena per la donna e il centauro per l’uomo, proprio per la
loro natura duplice e difforme sono il simbolo dell’inganno e dell’impostura.
Trovo anche l’uccisione del maiale in un capitello che probabilmente
rappresenta il mese di novembre, periodo consacrato alla sua macellazione.
Essendo considerato un animale immondo, la sua uccisione potrebbe
simbolicamente rappresentare anche l’eliminazione dei vizi. Anche in questo
caso oggi propendiamo a considerarne le virtù culinarie. Termino questa
descrizione osservando due uccelli tra una vegetazione intrecciata sul portale
d’ingresso che becchettano felici un grappolo d’uva, evidentemente un
riferimento all’eucarestia.





Paolo Moraschini
Bibliografia:
Sandro Chierici, La Lombardia, Ed. Jaca Book
Luca Frigerio, Bestiario medievale, Ed. Ancora