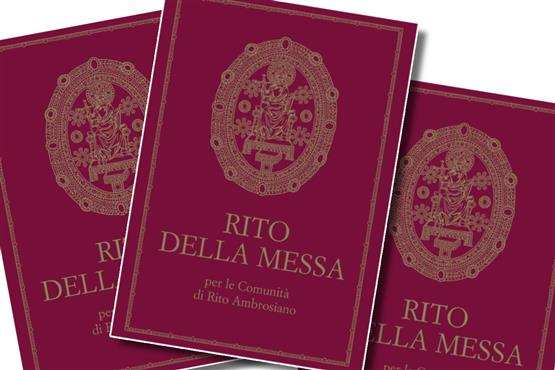La felicità della povertà
Povera fin dalla nascita. Anna Mazzoleni dice di aver conosciuto la povertà fin dalla sua nascita. Correva infatti l’anno 1943 quando è venuta alla luce; a quel tempo, la guerra pulsava nelle viscere del mondo e nella sua famiglia, composta da mamma, papà e tre sorelle, avere lo stomaco vuoto rappresentava la normalità: «La mia famiglia era abituata a non avere nulla. Riuscivamo ad andare avanti solo perché c’era una signora, un’ex suora comunista che faceva l’edicolante di Redona, e che in qualche modo, tutte le sere, si presentava da noi con un pentolino di brodo, e ogni tanto addirittura con un pezzetto di carne». Suo padre lavora giorno e notte, certo, ma «siccome incontrava gente che aveva meno soldi di lui e la povertà gli imponeva di condividere sempre, in tasca non gli restava nulla».
E proprio quando sembra che le cose prendano una piega migliore, il padre muore in un incidente in fabbrica. «A quel punto fu peggio di prima, perché l’azienda, all’epoca, non dava l’indennizzo. Ora Anna ha undici anni quando inizia a lavorare come bambinaia. Lascia la vita da studentessa. che ama per aiutare in casa, e a poco valgono le telefonate della maestra che sprona la madre a farla continuare sulla strada dei libri.
Gli studi da infermiera. Riesce a proseguire solo quando viene assunta alla clinica Gavazzeni, dove lavora e studia contemporaneamente, finché nel giro di un anno completa le scuole medie. «Da lì ho fatto il corso di infermiera ed è stato in quei tempi che ho cominciato a sognare l’Africa, speravo di andare in Uganda. Ma allora, per andarci, occorreva essere suore, e io non avevo alcuna intenzione di diventar lo». Ad Anna, infatti, le suore non sono mai piaciute, perché «da piccola, per qualche strana ragione, erano certi che lo sarei diventata. Passavo con loro tanto tempo. Eppure non mi avevano mai lasciato una buona impressione. Mangiavo con loro in refettorio, e ricordo che le vedevo rubare la mela più bella dagli altri vassoi».
In Bolivia con don Bepo. Il colpo d’ala nella vita di questa bergamasca dalla pelle dura avviene nel ‘66, grazie a don Bepo Vavassori, che un giorno di quell’anno si presenta in Gavazzeni, nel reparto di cardiologia. Dice di aver bisogno di un elettrocardiogramma per un viaggio molto delicato che deve intraprendere. Destinazione Bolivia. «Ci spiegò che sarebbe andato là ad aprire una casa per gli orfani in Bolivia. Io non ci sono stata tanto a riflettere. Ci accordammo e lo raggiunsi due mesi dopo. I bambini della Ciudad del Nino inizialmente erano settanta, in poche settimane diventarono trecento. Mi accorsi che ero scappata dalla povertà che da sempre mi aveva accompagnata per finire in una povertà ancora più radicale, più profonda. E in mezzo a quella povertà, ho vissuto gli anni più felici della mia vita». In Sudamerica Anna si trova a sperimentare situazioni disperate che le riempiono la vita.
La felicità della povertà. Rintraccia le orme di quel nutrimento dello spirito garantito dal possedere nulla, che lei così facilmente associa alla sua infanzia bergamasca. «La povertà mi è sempre piaciuta, ne ho sempre goduto. Perché era una condizione in cui mi scoprivo contenta. Quando ero bambina, tutti i miei vicini di casa, tutti i miei parenti erano poveri, eppure si viveva contenti, bastava un po’ di pane, di pasta, un po’ del frutto della nostra fatica per sentirci felici. Quando tornavamo dal mugnaio cantavamo, con gli zoccoli in mano altrimenti si consumavano. Si aspettava la sera, per riunirci su un muretto a cantare a squarciagola, felici, anche se con lo stomaco mezzo vuoto. Lo stesso sentimento l’ho ritrovato in Bolivia. E ho scoperto che più cose ci mancavano, più fatica si faceva, e più eravamo contenti. L’allegria che si prova tra chi è povero non l’ho mai conosciuta tra chi invece ha tutto».
Il matrimonio all’improvviso. Anche il futuro marito di Anna, come lei, non ha niente. Ma tra i banchi di una scuola boliviana, trova comunque il coraggio di chiederle di sposarla. Potrebbe essere il comune lieto fine di una storia d’amore, nella normalità. Ma la normalità non fa al caso di Anna. Lei e il suo fidanzato, infatti, non si conoscono: «Mia madre era stata chiara con me. Dovevo diventare suora, o sposarmi. Perché ormai avevo ventisei anni, e temeva che restassi nubile e sola, senza di lei. Non era disposta a lasciarmi in Bolivia in quella condizione indefinita, e così mi serviva qualcuno da sposare, come scusa per rimanere lì. Finché un giorno mi si presentò questo ragazzo, di un anno più grande, e dal nulla mi chiese la mano. Io pensai che fosse pazzo, ma il giorno dopo arrivò con la fede. Mi scrisse una lettera in cui mi spiegava almeno chi fosse, cosa facesse nella vita. Attraverso un vescovo, io e mia madre scoprimmo che il ragazzo era povero, non aveva nulla. Ma per me e lei questo rappresentava l’ultimo dei problemi. La convinsi che lo conoscevo da anni. E così, il 30 aprile del 1970 mi sono sposata. Avevo paura di averla combinata grossa, a sposare uno sconosciuto, perlopiù boliviano. Perché là, la gente non si crea problemi a celebrare le nozze anche una decina di volte nel corso della vita. Avevo qualche dubbio. Invece, poi, imparai a volergli bene. E il matrimonio è durato trentuno anni».
L’abbandono da parte del marito. Dalle nozze nascono tre figli, che crescono abituati a vivere nella povertà e sotto il fondamentale precetto della condivisione prima di tutto. La vita sfila via liscia, fino a una mattina del 2001, quando il marito di Anna esce a riscuotere la pensione, per non tornare mai più: «Il giorno che se n’è andato io e miei figli l’abbiamo cercato dappertutto, temevamo il peggio. Avevamo denunciato la scomparsa, eravamo stati in ospedale, alla polizia, ovunque. Poche ore dopo scoprii attraverso uno dei miei figli che se n’era andato con una più giovane, con una di trent’anni, perché si era accorto che ero diventata vecchia e brutta. Non l’ho mai più rivisto. La delusione è stata incredibile soprattutto per i ragazzi. Perché io sapevo che come compagno non era mai stato un granché, era già capitato che qualche notte stesse fuori casa, per qualche avventura. Ma per loro era un mito, e io avevo sempre cercato di coprire tutti i suoi errori».
Dopo trentasette anni trascorsi in Sudamerica, divisa tra i vent’anni boliviani e i diciassette passati in Cile, Anna torna in terra orobica, insieme a due dei tre figli. «Ho scelto di ricominciare la mia vita in Italia perché i miei figli minacciavano di fare del male a loro padre, dicevano di essere pronti a vendicare tutto il dolore che ci aveva causato. Allora ho programmato di tornare qui, e li ho portati con me, ad eccezione del più grande, che là aveva già una famiglia. Ho sempre chiesto a loro di continuare a rispettarlo, perché nonostante tutto, resta il loro papà». Ma la passione per la povertà le è rimasta innervata tra le fibre. «Soldi, come sempre, non ne ho. Però vivo felice, voglio bene alle persone. Sono andata a vivere a Mozzo, e ho collaborato all’apertura di un centro Caritas in quella parrocchia. Quando se n’è andato via da lì mi ha chiesto di seguirlo al Patronato San Vincenzo e adesso mi divido tra questi due luoghi. È bello vivere con i poveri, mi piace stare con loro. Perché sono generosi, quel poco che hanno lo condividono».